|
n. 6 giugno 2001

Altri articoli disponibili
|
|
Le notti di Paolo
di Filippa Castronuovo
|
 |
 |
 |
 |
Camminiamo nella fede
non nella visione
|
|
|
 |
 |
 |
 |
«Camminiamo
nella fede e non nella visione…» scrive Paolo (2Cor 5,7).
Quest’espressione insinua, per caso, che la fede, più che essere luce
nella notte profonda, è un’angosciosa certezza?
E’ un fatto: la vita di Paolo si svolge in una
prolungata esperienza di notte, come fatica, incomprensione, oscurità
o, come alcuni sostengono, la sua vita è stata una lunga e continuata
Via Crucis1. Nella nostra riflessione seguiamo alcune indicazioni di
Luca negli Atti degli apostoli2 e di Paolo
stesso3. Punto di partenza
per entrare nel mondo spirituale di Paolo è l’evento basilare della
sua conversione4. Luca la narra tre volte. Ogni narrazione, incastonata
nella vita di Paolo, aggiunge nuovi particolari, in un crescendo
cristologico dell’avvenimento che lo ha investito.
Due domande e una risposta senza soluzione
immediata caratterizzano l’incontro-scontro di Paolo con Gesù.
«Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?».
«Chi sei, tu, o Signore?».
«Entra in città e ti sarà detto…». Da chi?
Come? Quando?
Paolo, reso cieco dalla luce abbagliante, entra in
città e condotto per mano dai compagni, raggiunge la casa di un
cristiano di nome Anania. Da questi riceve, e non da Gesù direttamente
o da Pietro, orientamento per la sua vita. La cecità che lo colpisce
non è da interpretare solamente in chiave cronicistica, è
un’esperienza profonda di tenebre. A contatto con Dio, che è luce,
l’uomo non può che vedersi tenebra. «Tu, Signore, rischiari le mie
tenebre», prega il salmista (cf Sal 17,29).
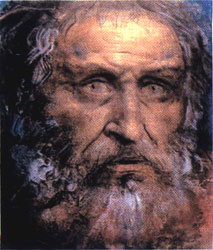
Dipinto di Pietro Annigoni (1910-1988).
Collezione privata.
I tre racconti lucani evidenziano l’oggettività
dell’esperienza paolina. Vi sono dei testimoni: essi o vedono la luce
o ascoltano la voce. La totalità dell’esperienza è solo di Paolo,
l’unico che entra nella notte, come morte, ed esce nel giorno, come
esperienza di vita nuova.
La prospettiva lucana, per la quale Dio dal buio
trae la luce, è cara anche a Paolo. Egli stesso interpreta il suo
incontro con Cristo, e la novità di vita da esso scaturita, in questi
termini:
«Dio che disse “dalle tenebre la luce
rifulga”, rifulse nei nostri cuori per l’illuminazione della
conoscenza della gloria di Dio sul volto di Cristo» (2Cor 4,6).
La luce che prese ad abitare nel cuore di Paolo è
Cristo Gesù, splendore del Padre, che, a sua volta, egli dovrà
comunicare.
1. Paolo strumento eletto
Nel primo racconto lucano, Gesù ad Anania,
titubante e incredulo circa la resa di Paolo, dice:
«Và, perché egli è per me uno strumento eletto
per portare il mio nome dinanzi ai popoli, ai re e ai figli di Israele;
e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome» (At 9,6).
La missione di Paolo, in quanto vaso d’elezione e
strumento eletto, si profila itinerante, costellata da prove e
persecuzioni, dalla sofferenza per il nome di Gesù. Sarà un ‘cammino
nella fede e non nella visione’ senza successi facili e immediati.
La conversione di Paolo solitamente si colloca tra il 34-35 e la
sua prima missione tra il 45-46. Tra la conversione e la prima missione
intercorrono 10 anni. Dove è stato Paolo? L’apostolo non accenna a
questo periodo. L’unico accenno è quello in 2Cor 11,31-33.
«Dio e Padre del Signore Gesù, lui che è
benedetto nei secoli, sa che non mentisco. A Damasco, il governatore del
re Areta montava la guardia alla città dei Damasceni per catturarmi, ma
da una finestra fui calato per il muro in una cesta e così sfuggii
dalle sue mani» (2Cor 11,31-33).
Luca colloca questo episodio subito dopo la
conversione e il battesimo ricevuto dalle mani di Anania (At 9, 30). Di
qui la domanda: che cosa sarà avvenuto nella prima fase cristiana di
Paolo? Coscienti della difficoltà di ricostruire le tappe di questo
primo periodo, possiamo ipotizzare che dopo la sua conversione, Paolo
comincia a predicare, ma è rifiutato sia a Damasco che a Gerusalemme.
Questi primi dieci anni, ricorda il cardinale Carlo Maria Martini5, sono
stati anni di difficoltà, di scontri, di disagi… di solitudine, di
silenzio, di sconforto. E’ la prima lunga notte per Paolo, cui ne
seguiranno molte altre. Un tentativo di uccisione a Damasco,
incomprensione a Gerusalemme, solitudine nel deserto. Che avrà vissuto
Paolo nel lungo isolamento che egli chiama deserto d’Arabia? Un
ricordo di Paolo può illuminare questo periodo di doloroso e
affascinante deserto:
«Bisogna vantarsi? Ma ciò non conviene! Pur
tuttavia verrò alle visioni e alle rivelazioni del Signore. Conosco un
uomo in Cristo che, quattordici anni fa - se con il corpo o fuori del
corpo non lo so, lo sa Dio - fu rapito fino al terzo cielo. E so che
quest’uomo - se con il corpo o senza corpo non lo so, lo sa Dio - fu
rapito in paradiso e udì parole indicibili che non è lecito ad alcuno
pronunziare. Di lui io mi vanterò! Di me stesso invece non mi vanterò
fuorché delle mie debolezze» (2Cor 12,1-5).
Tra gli interrogativi che affollavano la sua mente
e il suo cuore, nella crescente certezza che il crocifisso è veramente
il Messia, il Figlio di Dio così come le Scritture avevano predetto,
Paolo riceve consolazione e conforto da Dio. E’ un momento di luce e
di rinnovata esperienza di Dio, che sboccia in un nuovo cammino. Barnaba
va a cercarlo per condurlo nella comunità d’Antiochia. Purificato
dalla lunga notte dell’isolamento, sostenuto dall’approfondimento
dello scandalo del mistero pasquale, egli comincia ufficialmente la
missione e con essa la sua Via Crucis.
La notte più buia di Paolo...
...riguarda la rottura dell’amicizia con Barnaba,
l’unico che, quando tutti lo rifiutavano, “lo prese con sé e lo
presentò agli apostoli” e si fece garante della sua sincerità (cf At
9,26-27). Per un anno intero lavorano insieme. Paolo da Barnaba impara a
vivere in comunità e il metodo della missione. Con lui compie la prima
campagna missionaria in una collaborazione quasi idilliaca. Compiuto il
viaggio si preparano per il secondo. Barnaba vuole riportare in missione
Marco, benché questi, durante il primo viaggio, per timore, fosse
tornato indietro. Paolo non è d’accordo. Luca annota: “Il dissenso
fu tale che si separarono” (At 15,39). La collaborazione e l’armonia
si spezzano per l’irrigidimento di Paolo su di un principio relativo,
anzi per un dettaglio apostolico. La missione andrebbe avanti lo stesso
anche se Marco dovesse tornare indietro! Quando Paolo arriva alla piena
conoscenza di Cristo, scrive: « Se io parlassi tutte le lingue degli
angeli, ma non avessi l’amore sarei un nulla… L’amore è paziente,
non si adira l’amore» (cf 1Cor 13,1ss). E’ stata necessaria la
notte che ha segnato la rottura di una antica amicizia, di un vincolo
profondo. Queste ferite nel cuore di Paolo, si fanno memoria che salva6.
La notte dell’intolleranza si trasforma nel giorno della maternità
che cura e della paternità che incoraggia, ed esorta a camminare verso
Dio (cf 1Ts 2,7).
La notte come fatica a discernere le vie della
missione
Paolo e Silvano riprendono la seconda campagna
missionaria. La missione, ben preparata e organizzata, si presenta piena
d’imprevisti. Ogni aspetto chiaro diventa oscuro. Luca narra:
«Attraversarono quindi la Frigia e la regione
della Galazia, avendo lo Spirito Santo vietato loro di predicare la
parola nella provincia di Asia. Raggiunta la Misia, si dirigevano verso
la Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro» (At 16,6-7).
Questo impedimento si rivela di particolare
ricchezza missionaria. Paolo, durante la notte, vede il macedone che lo
invita a predicare Cristo nella sua terra (At 16,9). Alcuni fatti
impediscono lo svolgimento della missione, secondo i piani stabiliti da
Paolo e da Silvano. Queste difficoltà sono lette come segni di cui Dio
si serve per spostare gli orizzonti della missione, secondo la guida di
Dio.

Mosaico, secolo VI, Ravenna, battistero
degli ariani.
Notte di liberazione e di vita
Paolo giunge a Filippi. Qui viene catturato e
condotto nell’angolo più angusto della prigione in mezzo a una folla
di prigionieri disperati.
«La folla allora insorse contro di loro, mentre i
magistrati, fatti strappare loro i vestiti, ordinarono di bastonarli e
dopo averli caricati di colpi, li gettarono in prigione… Egli (il
carceriere), ricevuto quest’ordine, li gettò nella cella più interna
della prigione e strinse i loro piedi nei ceppi. Verso mezzanotte Paolo
e Sila, in preghiera, cantavano inni a Dio, mentre i carcerati stavano
ad ascoltarli» (cf At 16,23ss).
Il momento più intenso avviene nel cuore della
notte. Paolo, stordito dai colpi, sicuramente non trova una posizione di
sollievo. Grida di prigionieri arrivano alle sue orecchie. Passa il
primo turno di veglia della notte. Paolo soffre per il nome di Gesù.
Come ha imparato da ragazzo benedice Dio: «Benedetto Dio che illumina
il mondo con il suo splendore»7. Segue il terremoto che spalanca le
porte permettendo ai carcerati di fuggire. Il carceriere vuole uccidersi
ma Paolo lo assicura che nessun prigioniero è fuggito. Questi ‘preso
un lume nella notte’ si getta ai piedi di Paolo, accogliendone il
Vangelo. A queste memorie di Luca sembrano corrispondere alcuni ricordi
di Paolo nella 1Ts:
«Voi stessi, infatti, fratelli, sapete bene che la
nostra venuta in mezzo a voi non è stata vana. Ma dopo avere prima
sofferto e subìto oltraggi a Filippi, come ben sapete, abbiamo avuto il
coraggio nel nostro Dio di annunziarvi il vangelo di Dio in mezzo a
molte lotte» (1Ts 2,1-2).
Notte di fuga
Liberati dal carcere sono invitati a fuggire.
Fermarsi a Filippi è pericoloso. La folla è inferocita. Partono per
Tessalonica. Anche in questa città scoppia un subbuglio.
«Ma i fratelli subito, durante la notte, fecero
partire Paolo e Sila verso Berèa. Giunti colà entrarono nella sinagoga
dei Giudei… Molti di loro credettero e anche alcune donne greche della
nobiltà e non pochi uomini» (At 17,11-12).
Paolo è colmo d’afflizione e di preoccupazione.
Avrò fatto bene a fuggire da Tessalonica? Avranno forza questi neofiti
di sopportare la persecuzione? Come completare l’annuncio appena
iniziato? Questi interrogativi colmano il suo cuore di tristezza e hanno
i tratti del buio della notte. Egli scrive:
«Quanto a noi, fratelli, dopo poco tempo che
eravamo separati da voi, di persona ma non col cuore, eravamo
nell’impazienza di rivedere il vostro volto, tanto il nostro desiderio
era vivo. Perciò abbiamo desiderato una volta, anzi due volte, proprio
io Paolo, di venire da voi, ma satana ce lo ha impedito…Per questo,
non potendo più resistere, abbiamo deciso di restare soli ad Atene e
abbiamo inviato Timòteo…» (1Ts 2,17-18;3,1-3).
Notte di lacrime
Paolo passa a Corinto dove si ferma in tutto circa
due anni. A questa comunità scrive (cf 1Cor 15,30-32):
«Non vogliamo, infatti, che ignoriate, fratelli,
come la tribolazione che ci è capitata in Asia ci ha colpiti oltre
misura, al di là delle nostre forze, sì da dubitare anche della vita.
Abbiamo ricevuto su di noi la sentenza di morte… Da questa morte Dio
ci ha liberati…» (2Cor 1,8). «Infatti, da quando siamo giunti in
Macedonia, la nostra carne non ha avuto sollievo alcun ma da ogni parte
siamo tribolati: battaglie all’esterno, timori al di dentro» (2Cor
7,5).
Questi versetti comunicano la realtà faticosa
della missione, vissuta nella fragilità della realtà umana e lasciano
intuire la complessità della comunità di Corinto. La tradizione ci ha
trasmesso due lettere di Paolo a questa comunità ma l’apostolo ne ha
scritto quattro. Tra queste la cosidetta ‘lettera delle lacrime’ (cf
2Cor 2,3-4). I cristiani a Corinto volevano aderire alla falsa sapienza
che riduce la fede a una filosofia; avevano interpretato la libertà
cristiana come libertinismo e non come servizio e attenzione al
fratello. Stavano costruendosi un sincretismo religioso, una religione
‘fai da te’. Paolo era considerato uno che ‘di lontano con le
lettere sembrava forte, ma visto da vicino, valeva poco’ ...una
persona da poco conto, meschino!
«Ora io stesso, Paolo, vi esorto per la dolcezza e
la mansuetudine di Cristo, io davanti a voi così meschino, ma di
lontano così animoso con voi; vi supplico di far in modo che non
avvenga che debba mostrare, quando sarò tra voi, quell’energia che
ritengo di dover adoperare contro alcuni che pensano che noi camminiamo
secondo la carne» (2Cor 10,1-2).
La predicazione di Paolo non avveniva a ‘colpi di
miracoli’ o a forza di dimostrazioni razionali. Gli altri predicatori
avevano un certo ‘di più’. L’apostolo si difende dimostrando che
il vero di più consiste in di più di fatica, di sofferenza, di
profonda notte vissuta per il Signore (cf 2Cor 4,8-12; 6,8-10). Il vero
di più è la preoccupazione materna e paterna per le Chiese.
«Sto per dire una pazzia, io lo sono più di loro:
molto di più nelle fatiche, molto di più nelle prigionie,
infinitamente di più nelle percosse, spesso in pericolo di morte.
Cinque volte dai Giudei ho ricevuto i trentanove colpi; tre volte sono
stato battuto con le verghe, una volta sono stato lapidato, tre volte ho
fatto naufragio, ho trascorso un giorno e una notte in balìa delle
onde. Viaggi innumerevoli, pericoli di fiumi, pericoli di briganti,
pericoli dai miei connazionali, pericoli dai pagani, pericoli nella città,
pericoli nel deserto, pericoli sul mare, pericoli da parte di falsi
fratelli; fatica e travaglio, veglie senza numero, fame e sete,
frequenti digiuni, freddo e nudità. E oltre a tutto questo, il mio
assillo quotidiano, la preoccupazione per tutte le Chiese. Chi è
debole, che anch’io non lo sia? Chi riceve scandalo, che io non ne
frema?» (2Cor 11,23-29).
Che notte per Paolo quella nella quale i cristiani
di Corinto volevano dividersi da lui, il padre nella fede, che li aveva
generati a Cristo mediante il Vangelo!
Che esperienza di luce e di pieno giorno quando
Tito gli comunica che i figli di Corinto hanno riconosciuto il loro
errore e hanno mostrato pentimento per avere offeso Paolo, forse anche
pubblicamente!
«Dio che consola gli afflitti ci ha consolati con
la venuta di Tito, e non solo con la sua venuta, ma con la consolazione
che ha ricevuto da voi. Egli ci ha annunziato infatti il vostro
desiderio, il vostro dolore, il vostro affetto per me, cosicché la mia
gioia si è ancora accresciuta» (2 Cor 7,6-7).
|
Dipinto di Meliore di Jacopo
(seconda metà
del sec. XIII).
Particolare della madonna
e i Santi
(Panznao - Montefalcone). |
 |
Notte di consolazione
I dolori di Paolo provengono dall’interno della
comunità ma anche dall’esterno. Paolo a Corinto, rifiutato dai
Giudei, decide di andare dai pagani (cf At 18, 5-6). Nel dolore del
rifiuto dei suoi fratelli nella fede dei padri, nel dolore dei cristiani
che travolgono il Vangelo, nella notte è consolato:
«E una notte in visione il Signore disse a Paolo:
“Non aver paura, ma continua a parlare e non tacere, perché io sono
con te e nessuno cercherà di farti del male, perché io ho un popolo
numeroso in questa città”. Così Paolo si fermò un anno e mezzo,
insegnando fra loro la parola di Dio» (At 18, 10-11).
Notte pasquale
Percorrendo l’itinerario lucano Paolo da Corinto
va ad Atene, poi a Efeso, fino a giungere al termine della terza
campagna missionaria a Troade. Ai cristiani di Troade, nella lunga
conversazione notturna, Paolo esprime i suoi desideri, le sue
preoccupazioni. La sua conversazione è intercalata da preghiere,
professione di fede. Giunge la mezzanotte. Fra gli ascoltatori un
giovane, preso dal sonno, cade dal piano superiore, entrando nel sonno
della morte (cf At 20,7ss). Paolo gli restituisce la vita. E dalla
conversazione passa al momento di spezzare il pane. Proprio come Gesù
che prima di andare a morire spezza il pane con i suoi!
Il Risorto è, certamente, vivo e presente in mezzo
a loro, nel segno del pane e del vino. E’ presente anche nel gesto di
Paolo che riconsegna Eutico vivo a sua madre. Un gesto importante per
dire che la morte è sconfitta dalla vita, la notte dal giorno. Paolo
riprende il suo viaggio fino, quasi, alle porte di Efeso, ma si ferma al
porto di Mileto. Da qui fa chiamare gli anziani di Efeso. Perché non è
andato a incontrarli direttamente? Dobbiamo supporre che non va ad Efeso
perché qualche mese prima avevano tentato di ucciderlo? La risposta è
difficile. A noi rimane il discorso-testamento di Paolo agli anziani di
Efeso. Paolo leggendo il suo passato, il presente ed il futuro, presenta
il modello del pastore, che dà tutto se stesso senza risparmio.
«Quando essi [anziani] giunsero disse loro: “Voi
sapete come mi sono comportato con voi fin dal primo giorno in cui
arrivai in Asia e per tutto questo tempo: ho servito il Signore con
tutta umiltà, tra le lacrime e tra le prove che mi hanno procurato le
insidie dei Giudei… Ed ecco ora, avvinto dallo Spirito, io vado a
Gerusalemme senza sapere ciò che là mi accadrà. So soltanto che lo
Spirito Santo in ogni città mi attesta che mi attendono catene e
tribolazioni… » (cf At 20,18-23).
2. Paolo testimone-martire
Paolo si sta recando verso Gerusalemme ed ecco il
secondo racconto della vocazione che interpreta la vita di Paolo come
testimonianza fedele fino alla morte.
«Il Dio dei nostri padri ti ha predestinato a
conoscere la sua volontà, a vedere il Giusto e ad ascoltare una parola
dalla sua stessa bocca, perché gli sarai testimone davanti a tutti gli
uomini delle cose che hai visto e udito» (At 22,15 ).
Dio ha reso Paolo vaso di elezione (At 9,6), ma
anche testimone-martire. Testimone nella misura che vede il giusto e
ascolta una parola dalla sua bocca. Vedere e ascoltare sono i verbi
della relazione che si fa comunicazione. Il vedere di Paolo è
esperienza, l’ascolto è obbedienza della fede. Questo modo di vedere
e di ascoltare rende Paolo capace di comunicare il vangelo non con uno
stile dogmatico impositivo, ma come appello che tocca la profondità del
cuore, dove avvengono le decisioni (cf 1Ts 2,3). Secondo Luca una linea
ideale collega Gerusalemme e Roma. A Gerusalemme nasce la Chiesa; da
Roma questa si espande fino ai confini del mondo. Paolo arriva nel cuore
dell’impero non in trionfo ma all’interno di un processo ingiusto e
doloroso, come è avvenuto per Gesù. Il Signore lo incoraggia:
«La notte seguente gli venne accanto il Signore e
gli disse: “Coraggio! Come hai testimoniato per me a Gerusalemme, così
è necessario che tu mi renda testimonianza anche a Roma”» (At
23,11).
Come Gesù va a Gerusalemme, così Paolo va a Roma
a vivere la sua notte pasquale. A Luca sta a cuore indicare Paolo
modello del vero discepolo che percorre la strada del Maestro e lo
rappresenta. L’ultima parte degli Atti forma un chiaro parallelismo
tra la passione di Gesù e quella di Paolo. “Il discepolo non è più
del maestro; ma ognuno ben preparato sarà come il suo maestro” (Lc
6,40) sembra il quadro che meglio rappresenta
Paolo descritto da Luca.
Gesù va a Gerusalemme: Lc 9,51
Testimonianza davanti al Sinedrio: Lc 22,66ss.
Gesù lasciato ai giudei: Lc 23,1ss
Gesù resta solo: durante il processo dove sono i
dodici?
Paolo va a Gerusalemme: Atti 21,1ss
Testimonianza davanti al sinedrio: Atti 23,1ss.
Paolo lasciato ai giudei: 23,12ss.
Paolo resta solo quando è accusato: dove sono i
suoi?
«Secondo gli ordini ricevuti, i soldati presero
Paolo e lo condussero di notte ad Antipàtride. Il mattino dopo,
lasciato ai cavalieri il compito di proseguire con lui, se ne tornarono
alla fortezza. I cavalieri, giunti a Cesarèa, consegnarono la lettera
al governatore e gli presentarono Paolo» (At 23,31-33).
3. Paolo ministro-profeta
Nel cammino di identificazione cristocentrica,
Paolo lucano comprende gli orizzonti sconfinati della prima Damasco.
E’ vaso di elezione, testimone-martire,
ministro e profeta delle cose che ha già viste e di quelle che vedrà
ancora. La conversione come passaggio dal buio alla luce, come apertura
di orecchie deve continuare fino alla morte. Paolo, mediante il dono del
Vangelo, apre gli occhi ai ciechi, fa sì che le tenebre che avvolgono e
affliggono l’umanità lascino posto al giorno.
«Su, alzati e rimettiti in piedi; ti sono apparso
infatti per costituirti ministro e testimone di quelle cose che hai
visto e di quelle per cui ti apparirò ancora. Per questo ti libererò
dal popolo e dai pagani, ai quali ti mando
ad aprir loro gli occhi, perché passino dalle tenebre alla luce
e dal potere di satana a Dio e ottengano la remissione dei peccati e
l’eredità in mezzo a coloro che sono stati santificati per la fede in
me» (At 26,16-18).
La grande notte verso il giorno pieno
Nel parallelo lucano tra Paolo e Gesù, la grande
notte di Gesù si conclude con la morte e la risurrezione a Gerusalemme,
per Paolo nell’esperienza di morte vissuta simbolicamente nel
naufragio a Malta. Qui Paolo con i compagni passa la prova delle acque
(segno della morte). Egli ne esce vivo e fa uscire vivi gli altri, con
lui. Gesù dopo la sua morte riceve la gloria, aprendo a noi le porte
della salvezza; Paolo a Roma, cuore del mondo, annuncia la Parola di
salvezza.
|
S. Paolo,
quadro presente
nella cappella
di Iconio. |
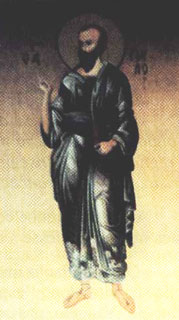 |
« Da vari giorni non comparivano più né sole, né
stelle e la violenta tempesta continuava a infuriare, per cui ogni
speranza di salvarci sembrava ormai perduta… Da molto tempo non si
mangiava, quando Paolo, alzatosi in mezzo a loro, disse: “Sarebbe
stato bene, o uomini, dar retta a me e non salpare da Creta; avreste
evitato questo pericolo e questo danno... Mi è apparso infatti questa
notte un angelo del Dio al quale appartengo e che servo, dicendomi: Non
temere, Paolo; tu devi comparire davanti a Cesare ed ecco, Dio ti ha
fatto grazia di tutti i tuoi compagni di navigazione. Perciò non
perdetevi di coraggio, uomini; ho fiducia in Dio che avverrà come mi è
stato annunziato. Ma è inevitabile che andiamo a finire su qualche
isola”. Come giunse la quattordicesima notte da quando andavamo alla
deriva nell’Adriatico, verso mezzanotte i marinai ebbero
l’impressione che una qualche terra si avvicinava» (cf At 27,9ss).
Per la terza volta, come tre sono i racconti della
vocazione, Paolo riceve l’incoraggiamento “non temere” nel cuore
della notte.
-
Non temere, Paolo, ma continua a parlare.
-
Coraggio! Come hai testimoniato per me a Gerusalemme, così è
necessario che tu mi renda testimonianza anche a Roma.
-
Non temere, Paolo; tu devi comparire davanti a Cesare ed ecco,
Dio ti ha fatto grazia di tutti i tuoi compagni di navigazione.
Il giorno glorioso di Paolo
«Paolo finalmente giunge a Roma; i fratelli gli
vengono incontro ed egli «al vederli, rese grazie a Dio e prese
coraggio. Arrivati a Roma, fu concesso a Paolo di abitare per suo conto
con un soldato di guardia».
«Paolo trascorse due anni interi nella casa che
aveva preso a pigione e accoglieva tutti quelli che venivano a lui,
annunziando il regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il Signore
Gesù Cristo, con tutta franchezza e senza impedimento» (cf At
28,16ss).
A noi piacerebbe conoscere la conclusione della
vita di Paolo. Luca non ha interesse a narrarla.
«Quando Paolo muore a Roma ha appena
sessant’anni. Metà della sua vita, dopo l’esperienza di Damasco,
l’ha passata da pellegrino del Vangelo, passando da una provincia
all’altra dell’impero, dalla Siria alla Galazia, dalla Macedonia
all’Acaia e all’Asia. Ha percorso una decina di migliaia di
chilometri, via terra e per mare. Egli ha desiderato e atteso il viaggio
a Roma come punto di partenza per la missione in occidente. Vi è
arrivato come prigioniero per il Vangelo e con la sua decapitazione ha
posto il sigillo alla sua testimonianza. Paolo non ha fondato la Chiesa
di Roma, ma con il suo “martirio” ne ha segnato per sempre la
storia. Il suo primo biografo Luca, anche se ha steso un velo sulla sua
condanna a morte nella capitale dell’impero, ha intuito la dimensione
storica e simbolica della sua testimonianza. La morte di Paolo a Roma
rappresenta il compimento della missione affidata da Gesù risorto ai
suoi discepoli, perché da questo centro giungesse in tutto il mondo»8.
Conclusione
All’inizio di questa riflessione ci siamo
domandati se la fede, per caso, fosse più che luce, un’angosciosa
certezza. Paolo ci ha testimoniato che la fede è un luminoso incontro
con Dio che in Gesù dà significato al non senso umano, e al tragico
che caratterizza la nostra esistenza. Il cammino nella fede e non nella
visione che caratterizza Paolo e ognuno di noi, è il cammino percorso
dal Figlio di Dio “il quale essendo di condizione divina” accetta di
camminare nell’oscurità, assumendo la condizione di servo fino alla
morte di croce. L’autore dello scritto agli Ebrei lo ricorda
chiaramente: «Nei giorni della sua vita terrena pianse...» (Eb 5,7-8).
Dall’alto della croce Gesù, tentato dai suoi denigratori, accettò la
sua ‘notte’. Non scese miracolisticamente in mezzo agli uomini, ma
si abbandonò (cadde) nelle mani del Padre. Così la notte più
tenebrosa della storia si trasformò nel giorno glorioso, senza fine.
Paolo dal canto suo afferma: «Nessuno mi dia fastidi, io porto nel mio
corpo le stigmate di Cristo» (Gal 6,17).
Il credente, testimonia Paolo, non si ritiene
esonerato dall’angoscia, dalla fatica di entrare nella notte, dallo
smarrimento e dalla paura. Chi crede guarda Gesù la cui esistenza è
stata una lotta contro la tentazione e la prova, un entrare nella morte
per uscire nella vita o entrare nella notte per divenire giorno pieno.
Paolo, che ha imparato a vivere le notti della incomprensione, della
persecuzione, della fede, afferma con certezza che noi siamo “figli
della luce e del giorno” (cf 1Ts 5,4). Mentre ripete: «Fatevi miei
imitatori come io lo sono di Cristo» (1Cor 11,1) consegna il grande
segreto che rese luminose le sue notti : «Mi amò e ha consegnato se
stesso per me» (cf Gal 2,20). Ecco la sua certezza straordinaria: «Ti
basta la mia grazia», cioè il mio amore forte come la morte. Di qui
l’abbandono fiducioso e intraprendente: «Quando sono debole è allora
che sono forte» (cf 2Cor 12,7-12).
La fede, perciò, non è un’angosciosa certezza,
ma una luminosa speranza, fondata sulle basi sicure dell’amore di Dio.
Per me egli ha dato suo Figlio. E se Dio è con noi chi sarà contro di
noi? Chi potrà separarci dal suo amore? Niente e nessuna creatura ci
potrà mai separare dal suo amore (cf Rm 8,39). La stessa morte, madre
di tutte le notti e delle paure a essa connesse, “ è stata ingoiata
per la vittoria”. «Siano rese grazie a Dio che ci dà vittoria per
mezzo del Signore nostro Gesù Cristo!» (cf 1Cor 15,56), che è il
nostro giorno senza fine.
 |
|
|